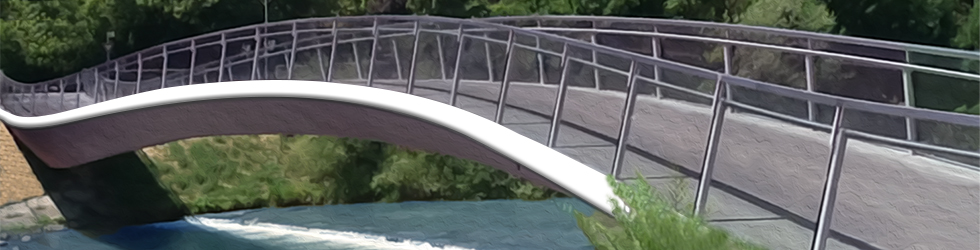Questo sito utilizza cookie (tecnici), per gestire e migliorare la tua esperienza di navigazione online . Puoi modificare le tue scelte in ogni momento.
Una provincia forte con un capoluogo debole.
Tuesday , 5, November 2013 Lavoro e Impresa, Memoria, Società Comments Off on Una provincia forte con un capoluogo debole.Bolzano ha sempre avuto un rapporto complicato col proprio territorio, la provincia di cui é capoluogo. O meglio, la provincia nel suo complesso fa fatica a riconoscersi nel suo capoluogo: storie, lingue, maggioranze etniche, strutture sociali diverse.
É giusto sperare che la prossima legislatura provinciale migliori questo rapporto, anche se le premesse elettorali non sono le più incoraggianti.
Per un nuovo rapporto Bolzano-provincia, si dovranno peró riconoscere e considerare le nuove e crescenti differenze tra la città capoluogo ed il territorio. Bolzano é una città vecchia (44 anni età media) in una provincia (relativamente ) giovane (41 anni età media). Bolzano ha meno “famiglia” nel senso tradizionale del termine: 40% delle famiglie sono unifamiliari contro il 34 % della media provinciale. E poi la forza lavoro: a Bolzano l “indice di ricambio” é 125 : a 5 persone che escono dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età, corrispondono 4 persone in età lavorativa. Nel resto della provincia siamo a 93: piú persone che entrano nel mondo del lavoro rispetto a quelli che escono.
Insomma, Bolzano é piú speciale in una provincia già speciale. Piú vecchia e piú debole.
Saperlo é già una buona base per ragionare e cercare le politiche giuste.
Una guerra, due diversi film.
Sunday , 3, November 2013 Memoria Comments Off on Una guerra, due diversi film.4 novembre, anniversario della Vittoria. É passato quasi un secolo dalla prima guerra mondiale, ma la memoria collettiva é ancora viva. Uno dei conflitti piú sanguinosi della storia d’Europa e del mondo, che ha avuto un suo epicentro nella nostra regione. Molte migliaia di morti, militari e civili, trentini e sudtirolesi. Altrettante vittime militari italiane. Un’enorme tragedia che ha colpito quasi tutte le famiglie di noi attuali abitanti di questa regione, con i nostri nonni o bisnonni schierati su fronti opposti. I trentini ed i sudtirolesi coinvolti nella guerra a partire dal 1914, italiani mobilitati dal 1915. Due date, due esperienze contrapposte: guerra 14-18 dalla parte dell’Austria-Ungheria i primi, guerra 15-18 dalla parte dell’Italia, i secondi, gli uni contro gli altri.
Una guerra, due film diversi: una vittoria, una sconfitta, un sacro confine a Brennero, un confine ingiusto. Nel 2014 cadono i cent’anni dall’inizio della prima guerra mondiale per trentini e sudtirolesi, nel 2015 per l’Italia e gli italiani. Ci saranno celebrazioni diverse per una guerra vissuta su fronti diversi. Ce la faremo noi cittadini di questa regione a scrivere definitivamente un finale comune e condiviso per questi due diversi film? L’appuntamento é per il 2019, a cent’anni dai trattati di pace. Il tempo c’é: ce la possiamo fare!
Potrei, ma non voglio.
Saturday , 2, November 2013 Lavoro e Impresa Comments Off on Potrei, ma non voglio.Sembra incredibile, ma ci sono temi per i quali la Provincia di Bolzano non vuole essere autonoma. Tra questi, uno é quello del lavoro, inteso come opportunità di incontro tra la domanda e l’offerta i posti di lavoro. Un tema non da poco se pensiamo agli oltre 13.000 altoatesini disoccupati, ma anche al tanto “lavoro che cerca invano lavoratori”. Quello che serve urgentemente é quindi un sistema efficiente di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per favorirne l’incontro.
Semplice, no? Nient’affatto! In Alto Adige applichiamo le stesse leggi poco efficaci del resto d’Italia (dove la disoccupazione é tripla della nostra) e non riusciamo ad essere i primi della classe come in altri campi. Anzi, la Provincia di Trento, ad esempio, ci supera istituendo in maniera autonoma l’Agenzia del Lavoro e utilizzando le competenze autonomistiche per gli ammortizzatori sociali.
A Bolzano, in questa materia, siamo rimasti inspiegabilmente timidi. Continuare ad applicare leggi statali inadatte al nostro territorio, lamentandosi e criticando Roma, non diminuisce le nostre responsabilità verso i nostri concittadini senza lavoro e verso le nostre imprese che cercano lavoratori e non li trovano.
La debacle dell’economia ha anticipato quella della politica.
Friday , 1, November 2013 Lavoro e Impresa, Memoria Comments Off on La debacle dell’economia ha anticipato quella della politica.Gli italiani in consiglio provinciale contano il 14%. Quanto contano nell’economia altoatesina? É difficile stabilire una percentuale, ma la debacle italiana nell’economia ha anticipato di anni quella della politica. A parte il Pubblico Impiego, dove vige la proporzionale etnica e quindi una garanzia minima per gli italiani, nei settori dell’economia privata il declino è evidente. L’ ultima mazzata, la crisi irreversibile dell’edilizia, settore nel quale una parte consistente del gruppo italiano ha sempre esercitato le sue professioni e ricavato il suo reddito. Ma la ritirata italiana riguarda anche l’industria (soprattutto la grande industria di base), l’artigianato (ed ancora peggio l’apprendistato), ed il commercio. E molto si potrebbe aggiungere anche sulle libere professioni.
Anche per l’Economia, cosí come per la Politica, non si puó parlare delle “colpe dei tedeschi”, senza prima aver guardato ai ritardi italiani. E qui si torna al tema iniziale: una comunità come quella italiana dell’Alto Adige é destinata ad un continuo processo di marginalizzazione, se non si impegna essa stessa a sviluppare una propria identità locale, se non cura ed alimenta la sua cultura e se non si costruisce un sistema di rappresentanza politica su basi locali. E questi compiti non si possono affidare ai nostri concittadini di lingua tedesca. Tocca a noi!
“Ex malo, bonum”, ovvero tiriamo fuori il bene dal male. Dopo il disastro per gli italiani nelle elezioni provinciali, si puó finalmente parlare di loro (cioé di noi). Parlare della identità degli italiani dell’Alto Adige. Una identità diversa da quella del resto dell’Italia e quindi, proprio per questo, da sostenere ed alimentare con strumenti locali ad hoc. Ed é qui che che siamo all’anno zero, o quasi. La storia locale, l’economia locale, le istituzioni locali, l’Autonomia, fanno parte dell’insegnamento standard nelle scuole italiane?
La televisione pubblica Rai, ha autonomia, tempi e mezzi aggiuntivi per informare adeguatamente gli Altoatesini?
Bambini italiani che vengono iscritti nelle scuole materne e medie tedesche “cosí imparano il tedesco”, senza tener conto che una lingua é solo un aspetto di una cultura e di tradizioni proprie di un gruppo. Devono essere offerte anche altre vie verso “l’altoatesino nuovo”, quella seconda voce del dialogo interculturale su cui deve basarsi l’Autonomia dell’Alto Adige/ Südtirol. Ex malo, bonum; approfittiamo di questo amaro dopo-elezioni per avviare un confronto aperto sulla identità italiana in Alto Adige e su come essa possa giocare un ruolo importante per il futuro della nostra terra.